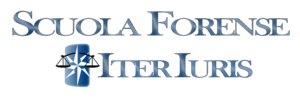Il datore di lavoro risponde del danno conseguente al mobbing dei dipendenti nei confronti del collega. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 4 dicembre 2020, n. 27913.
La Massima
A cura dell’avv. Eleonora Pedevillano
Quando i comportamenti tenuti dai dipendenti nei confronti di un collega siano idonei ad integrare la fattispecie di mobbing, il datore di lavoro risponde del conseguente risarcimento del danno da invalidità temporanea, ogni qual volta sia venuto a conoscenza delle condotte vessatorie e non abbia adottato gli opportuni provvedimenti per porvi fine.
Invero, lo stesso, sebbene non si sia reso direttamente protagonista delle condotte vessatorie, non può andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c., rivestendo, ex lege, una posizione di “garante” a tutela, anche, l’integrità psico-fisica del lavoratore.
La Nota
A cura dell’avv. Eleonora Pedevillano
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione adottata dalla Corte di Appello di Ancona che, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da una lavoratrice, aveva condannato la società datrice di lavoro a risarcire il danno da invalidità temporanea conseguente al mobbing patito dalla lavoratrice, vittima di reiterate vessazioni poste in essere dai colleghi.
Condividendo in toto l’iter motivazionale del giudice di secondo grado, secondo il quale il datore di lavoro che è a conoscenza dei reiterati episodi mobizzandi, ma non abbia attuato provvedimenti disciplinari idonei a tutelare la situazione (elementi provati dalla difesa della lavoratrice nel giudizio di merito), risponde del danno da invalidità temporanea conseguente al mobbing posto in essere dai dipendenti, la Suprema Corte evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017; 22710/2015; 18626/2013; 17092/2012; 13956/2012), la responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, avuto anche riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003).
Ne discende che, sebbene nel caso in esame il datore di lavoro non si fosse reso direttamente protagonista delle condotte vessatorie, tuttavia lo stesso, rivestendo una posizione di “garante” nei confronti dei suoi dipendenti, non potrà andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c., in quanto non ha mai reagito a tutela dell’integrità morale della lavoratrice vittima di mobbing.
Gli Ermellini richiamano, a proposito, quegli orientamenti dottrinali e la giurisprudenziali secondo i quali le disposizione della Carta costituzionale hanno segnato, anche nella materia giuslavoristica, un momento di rottura rispetto al sistema precedente ed hanno consacrato, di conseguenza, il definitivo ripudio dell’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l’agire privato”, in considerazione del fatto che l’attività produttiva – anch’essa oggetto di tutela costituzionale, poichè attiene all’iniziativa economica privata quale manifestazione di essa (art. 41 Cost., comma 1) – è subordinata, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, alla utilità sociale che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità.
Assumono, dunque, preminente valore, lo svolgimento della persona, il rispetto di essa, la sua dignità, sicurezza e salute, anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa, anche in considerazione del fatto che la mancata predisposizione di tutti i dispositivi atti a tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l’art. 32 Cost., che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell’individuo, ed altresì l’art. 2087 c.c., che, imponendo la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro prevede un obbligo, da parte di quest’ultimo, che attiene anche alla predisposizione “di misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell’ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio”.
Alla luce di queste considerazioni la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di parte datoriale, cristallizzando il diritto della lavoratrice vittima di mobbing al risarcimento del danno da invalidità temporanea.
Leggi il Provvedimento qui
Cassaziome, Sezione lavoro, sentenza 4 dicembre 2020, n. 27913
Clicca per leggere
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Fermo con la sentenza n. 17/2016, depositata il 26.1.2016, in parziale accoglimento del ricorso proposto da R.D., ha dichiarato la illegittimità del licenziamento alla stessa intimato dalla S.p.A. A.G., disponendo la reintegrazione della lavoratrice nel luogo di lavoro, ed ha condannato la società datrice al pagamento, in favore della prima, dell’indennità risarcitoria dal licenziamento sino alla effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi maturati e maturandi.
La Corte territoriale di Ancona, con sentenza pubblicata in data 19.1.2018, ha respinto l’appello principale interposto dalla A.G. S.r.l. (già A.G. S.p.A.), nei confronti della R., avverso la detta pronunzia, ed in parziale accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice, ha condannato la società al pagamento, in favore di quest’ultima, della somma di Euro 5.422,50, a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea conseguente al mobbing posto in essere nei suoi confronti, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
La Corte di Appello, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato che, nella fattispecie, “assume rilievo il fatto che A.G., rappresentante legale della società datrice, sia stato messo al corrente” dei reiterati “episodi mobizzanti posti in essere” nei confronti della dipendente, “ma non abbia voluto indagare a fondo la questione, nè attuare provvedimenti disciplinari idonei a tutelare la situazione problematica prospettatagli dalla R.”; che “gli atteggiamenti e i comportamenti tenuti dai dipendenti nei confronti della R. appaiono idonei ad integrare la fattispecie di mobbing, nei termini sintetizzati dall’ormai costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 24358/2017)… sussistendo, nel caso di specie, tanto il requisito oggettivo, quanto quello soggettivo. Il primo, costituito dalla pluralità di atti o fatti, caratterizzati da sistematicità, si è concretizzato con tutta evidenza, data la quotidianità delle offese e dei rimproveri ingiustificati con cui i dipendenti, in particolare la I. e la R., mortificavano la R.. L’elemento soggettivo risulta provato, invece, dall’offensività dei termini utilizzati e delle accuse assolutamente infondate dirette alla lavoratrice, suscettibili di evidenziare la volontà di prevaricazione dei suddetti dipendenti nei confronti della stessa”; ed inoltre, che “Nel caso in esame, sebbene il datore di lavoro non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie subite dalla R., tuttavia lo stesso non può andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c.. Il datore, in particolare, anche con riferimento all’episodio del luglio 2007, sebbene avesse udito le grida e sebbene fosse stato informato tanto dal R. quanto dall’appellata, non ha mai reagito a tutela dell’integrità morale di quest’ultima” (v. pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione (già A.G. S.r.l.) articolando quattro motivi, cui ha resistito R.D. con controricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione sollevata da R.D. nel controricorso circa la tardività della notifica del ricorso per cassazione, data la tempestività del ricorso della curatela fallimentare (avvenuta lunedì 4.6.2018), destinataria di notificazione a mezzo PEC il 4.4.2018, ed attesa la nullità di quella a mezzo PEC del 19.1.2018 ai
procuratori costituiti della società, essendone stato dichiarato il fallimento dopo la sentenza di appello in pendenza del termine per il ricorso per cassazione. Qualora, infatti, dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per la proposizione del gravame, intervenga il fallimento della parte, il ricorso per cassazione deve essere proposto e notificato nei confronti del fallimento, mentre ove sia proposto nei confronti del soggetto in bonis e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio di appello, è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 del codice di rito, ma la nullità è sanata dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare (cfr., tra le altre, Cass. n. 16070/2014).
Ciò premesso, occorre procedere all’esame dei mezzi di impugnazione articolati dalla società ricorrente.
1. Con il primo motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 58, lett. B), del CCNL Industria Calzature del 2.7.2008 e dell’art. 2110 c.c., “per non avere la Corte d’Appello considerato scaduto il periodo di conservazione del posto, essendo decorso il periodo di comporto e non spettando l’aspettativa”; in particolare, si lamenta che i giudici di secondo grado non avrebbero considerato che, ai sensi dell’art. 58, lett. B), del CCNL di settore, il periodo di aspettativa, successivo alla scadenza dei 13 mesi del periodo di comporto, potesse essere concesso solo in presenza di ricovero ospedaliero e/o terapia salvavita e che, nella fattispecie, non ricorrendo alcuna delle due circostanze, l’aspettativa non poteva essere concessa alla R. e, quindi, “il periodo di comporto iniziò a decorrere 90 giorni dopo l’inizio della assenza per malattia asseritamente causata da mobbing e, dunque, non computabile nel periodo di comporto, e precisamente in data 12.10.2007, per terminare 13 mesi dopo, ovvero in data 11.11.2008. Successivamente a tale data, il 16.12.2008, veniva irrogato il licenziamento, da ritenere perfettamente valido”.
2. Con il secondo motivo si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 58, lett. B), del CCNL Industria Calzature del 2.7.2008 “per non avere la Corte d’Appello considerato applicabile al caso di specie la normativa di cui al CCNL Industria Calzature del 2.7.2008” e si precisa che con tale motivo, “strettamente connesso al primo, si eccepisce una errata applicazione della norma di cui all’art. 58, lett. B), del CCNL Industria Calzature del 2.7.2008, modificativo del precedente”.
3. Con il terzo motivo si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. “per avere la Corte d’Appello ritenuto esistente la fattispecie di mobbing in assenza degli elementi costitutivi” ed avere ravvisato nella fattispecie un intento persecutorio in assenza di elementi probatori a sostegno.
4. Con il quarto motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo “per avere la Corte d’Appello omesso di considerare la mancata comunicazione al datore di lavoro dei comportamenti assunti come mobizzanti”.
1.1; 2.2. I primi due motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibili, perchè negli stessi si deduce la violazione dell’art. 58, lett. B), del CCNL Industria Calzature, che non è stato prodotto (e neppure indicato nell’elenco dei documenti offerti in comunicazione elencati nel ricorso per cassazione), nè trascritto per intero, ma solo relativamente ad alcune parti dell’art. 58, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (v., tra le altre, Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di potere compiutamente apprezzare la veridicità delle doglianze svolte dal ricorrente, il quale ultimo, peraltro, non ha neppure prodotto la documentazione relativa alla concessione del periodo di aspettativa alla R., da parte della società datrice, cui si fa riferimento, in particolare, nel primo mezzo di impugnazione.
3.3. Il terzo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto è ius receptum che la valutazione delle risultanze probatorie o processuali denunciabile in sede di legittimità deve riguardare specifiche circostanze oggetto della prova sulle quali il giudice di legittimità può esercitare il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (arg. ex Cass. nn. 21486/2011; 17915/2010); nella specie, si rileva che non sono state neppure riportate le dichiarazioni rese dai testi escussi, che si assumono erroneamente interpretate dalla Corte di merito; e ciò, ancora in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguenza che questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare la veridicità della censura sollevata (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013); a fronte cli ciò, va, altresì, osservato che i giudici di seconda istanza hanno compiutamente ed analiticamente esaminato tutte le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione oggetto del presente giudizio, tra le quali la c.t.u. che ha riconosciuto alla lavoratrice “un danno causato dal mobbing subito dalla stessa, corrispondente ad una inabilità temporanea per complessivi 90 giorni” (v. pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata).
Inoltre, occorre sottolineare, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017; 22710/2015; 18626/2013; 17092/2012; 13956/2012), che la responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, avuto anche riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003). Ed i giudici di seconda istanza, attraverso un iter motivazionale scevro da vizi logico-giuridici e fondato su una condivisibile valutazione degli elementi delibatori, si sono del tutto attenuti alla consolidata giurisprudenza di legittimità nella materia.
4.4. Il quarto motivo non può essere accolto, poichè, in realtà, come sottolineato in narrativa, la Corte di merito ha esaminato e valutato il fatto che il datore di lavoro fosse o meno al corrente “dei comportamenti assunti come mobizzanti” (v. pag. 15 della sentenza impugnata) ed al riguardo ha osservato che “Nel caso in esame, sebbene il datore di lavoro non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie subite dalla R., tuttavia lo stesso non può andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c.. Il datore, in particolare, anche con riferimento all’episodio del luglio 2007, sebbene avesse udito le grida e sebbene fosse stato informato tanto dal R. quanto dall’appellata, non ha mai reagito a tutela dell’integrità morale di quest’ultima” ed altresì che “Appare, inoltre, inverosimile che lo stesso non fosse a conoscenza dei comportamenti tenuti dalla dipendente I., in quanto molte circostanze gli sono state riferite direttamente dalla R.”. Con ciò, implicitamente sottolineando la posizione di “garante” che spetta inderogabilmente al datore di lavoro. Al riguardo, è altresì da osservare che la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno sottolineato come le disposizione della Carta costituzionale abbiano segnato anche nella materia giuslavoristica un momento di rottura rispetto al sistema precedente “ed abbiano consacrato, di conseguenza, il definitivo ripudio dell’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l’agire privato”, in considerazione del fatto che l’attività produttiva – anch’essa oggetto di tutela costituzionale, poichè attiene all’iniziativa economica privata quale manifestazione di essa (art. 41 Cost., comma 1) – è subordinata, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, alla utilità sociale che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità. Da ciò consegue che la concezione “patrimonialistica” dell’individuo deve necessariamente recedere di fronte alla diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute – anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa -; momenti tutti che “costituiscono il centro di gravità del sistema”, ponendosi come valori apicali dell’ordinamento, anche in considerazione del fatto che la mancata predisposizione di tutti i dispositivi atti a tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l’art. 32 Cost., che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell’individuo, ed altresì l’art. 2087 c.c., che, imponendo la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro prevede un obbligo, da parte di quest’ultimo, che non si esaurisce “nell’adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico”, ma attiene anche – e soprattutto – alla predisposizione “di misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell’ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio”. Tale interpretazione estensiva della citata norma del codice civile si giustifica alla stregua dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., già da epoca risalente, Cass. nn. 7768/95; 8422/97), sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute – art. 32 Cost., sia per il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio – artt. 1175 e 1375 c.c., disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi “normativi” e di clausole generali (Generalklauseln) – cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, “pur se nell’ambito della generica responsabilità extracontrattuale”, ex art. 2043 c.c., in tema di neminem laedere (al riguardo, questa Suprema Corte ha messo, altresì, in evidenza, da tempo, che, in conseguenza del fatto che la violazione del dovere del neminem laedere può consistere anche in un comportamento omissivo e che l’obbligo giuridico di impedire l’evento può discendere, oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività, a tutela di un diritto altrui, è da considerare responsabile il soggetto che, pur consapevole del pericolo cui è esposto l’altrui diritto, ometta di intervenire per impedire l’evento dannoso).
Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020
L\'autore
Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento scientifico di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.